Poche conoscenze e molti luoghi comuni circa il ruolo per l’uomo e l’ambiente contraddistinguono gli insetti pronubi “impollinatori”, quali le Api, tra cui la domestica, i Bombi e i Calabroni. Ecco una serie di nozioni che dovremmo tutti sapere.
Calabrone (Vespa Crabo)
Insetto Imenottero Aculeato tra i più grossi rappresentanti della famiglia dei Vespidi; lungo anche più di 3 cm, ha il grosso capo di colore rossastro con una banda gialla tra la base delle antenne; il torace è nero con macchie rossastre. Diffuso in Europa, vive in colonie e nidifica abitualmente in tronchi cavi, nei comignoli delle canne fumarie di case abbandonate, in piccole buche, o comunque in posti riparati, dove costruisce un nido con legno sfibrato impastato con saliva. La puntura delle femmine, munite di un robusto pungiglione, è molto dolorosa e potenzialmente pericolosa.

In molti temono i Calabroni, perché aggressivi e con una cattiva reputazione: distruggono e saccheggiano gli alveari delle api, ci fanno paura quando si avvicinano troppo, hanno un ronzio inquietante e un aspetto minaccioso.
In ambito medico-scientifico, i rischi sanitari per l’uomo sono di due tipi: il rischio diretto da puntura molto dolorosa e la possibilità di effetti anafilattici nei soggetti allergici (5-10 punture possono essere fatali). E’ bene che i soggetti più esposti a questo secondo rischio abbiamo a portata di mano medicamenti salvavita, in grado di contrastare gli effetti della puntura dei calabroni.
E’ bene che di rivolgano al loro medico per l’opportuna profilassi.
Ma i Calabroni non sono affatto inutili, perché questi grandi imenotteri, essendo predatori attivi, si nutrono di altri insetti, spesso dannosi per l’agricoltura e le foreste, quali sono i bruchi, le mosche afidi ed altri parassiti che possono infestare colture e boschi. In altre parole, i calabroni fanno da pesticidi naturali, contribuendo a contenere le popolazioni infestanti.
Ogni colonia può eliminare migliaia di prede in una sola stagione e, anche se non sono impollinatori specializzati come le api, visitano i fiori per nutrirsi di nettare. Inoltre i calabroni fanno parte di una catena alimentare quale nutrimento per uccelli, piccoli mammiferi e persino altri insetti. I predatori naturali come i pipistrelli, i gufi e i falchi possono essere utilizzati per controllare le popolazioni dei calabroni.
Essi sono quindi regolatori ecologici a tutti gli effetti, senza di loro gli ecosistemi perderebbero un alleato indispensabile.
Bombo (Bombus Terrestris)
l bombi sono impollinatori appartenenti alla stessa famiglia delle api da miele, ossia Apidae, ma sono più grandi e presentano una caratteristica soffice peluria che ne ricopre il corpo. Sono noti anche per le loro colorazioni vivaci, spesso a strisce nere e gialle, ma possono anche essere completamente neri o con bande arancioni.
I bombi sono insetti impollinatori molto efficaci, sia in campo aperto che in serra, grazie alla loro robustezza, peluria e capacità di regolare la temperatura corporea. Sono particolarmente apprezzati per l’impollinazione di colture come pomodori, fragole e altre piante da frutto.

L’impiego dei bombi in serra si è affermato da molti anni ed ha sostituito ormai completamente la pratica dell’ormonatura dei fiori. Ci sono aziende specializzate che hanno predisposto apposite arnie progettate per garantire alle colonie di Bombus Terrestris, le migliori condizioni per un corretto sviluppo. I bombi, come le api, si nutrono di nettare e polline, che trasformano in miele all’interno del loro corpo.
I bombi presentano differenze morfologiche tra maschi e femmine, e tra le femmine si distinguono regine e operaie. Le regine, le femmine fecondate che fondano nuove colonie, sono generalmente più grandi sia dei maschi che delle operaie e presentano caratteristiche distintive nel colore del corpo e delle ali. I maschi, invece, sono simili alle operaie in termini di dimensioni, ma possono essere distinti dalle mandibole più sviluppate.
Ape (Apis mellifera)
Insetto dell’ordine Imenotteri, superfamiglia degli Apoidei olometabolo, caratterizzato cioè da uno sviluppo postembrionale nel quale si distinguono le fasi di larva, pupa e immagine, è dotato di apparato boccale lambente succhiatore. Vive in società permanenti, matriarcali, monoginiche, in cui diversi individui si raggruppano nelle due caste degli anfigonici, o riproduttori, e delle operaie e hanno forme diverse in rapporto all’ufficio da compiere in favore della società.

La società delle Api comprende: una sola femmina feconda, la regina, destinata unicamente a deporre le uova. E’ la più grande di tutte le Api dell’alveare: raggiunge e supera i due cm di lunghezza, le ali non coprono l’ultima parte dell’addome; questo è fornito di un pungiglione che però non viene usato, se non contro altre regine. Agli inizi della vita da adulto, viene fecondata da 1-8 maschi durante alcuni voli di fecondazione, lo sperma è conservato in apposita vescicola (spermateca) e consentirà alla regina di fecondare le uova senza dover ricorrere a nuovi accoppiamenti; essa dura in vita 4-5 anni, deponendo sino a 2000 uova al giorno per tutta la durata della buona stagione.
L’ape domestica ha numerose sottospecie, ognuna delle quali si adatta a particolari condizioni di vita. Solo alcune di esse sono usate dagli apicoltori per la produzione del miele. Apis mellifera è il nome scientifico dell’ape domestica, storicamente presente in Europa e in Africa prima di essere introdotta negli altri continenti.
L’Italia è uno dei maggiori paesi produttori di miele. Tra le regioni, la Toscana produce circa 2.300 tonnellate di miele all’anno, che corrisponde al 10% della produzione nazionale, con un valore di circa 16 milioni di euro. La regione è riconosciuta per la varietà e la qualità del miele, con diverse tipologie prodotte a seconda delle fioriture locali.
Pochi sono, tuttavia, i veri e propri produttori, cosicché a fianco delle aziende che svolgono tale attività a carattere professionale, vi sono migliaia di dilettanti, che nel tempo si sono sostituiti ai monaci dei conventi e ai contadini, da sempre custodi di un allevamento più che millenario.
Sullo stato degli insetti pronubi “impollinatori”, riporto uno stralcio di testo di V. Silli, V. Bellucci – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
Il ruolo delle api per l’uomo e l’ambiente:
“ Più del 40% delle specie di invertebrati, in particolare api e farfalle, che garantiscono l’impollinazione, rischiano di scomparire; in particolare in Europa il 9,2% delle specie di api europee sono attualmente minacciate di estinzione (IUCN, 2015). Senza di esse molte specie di piante si estinguerebbero e gli attuali livelli di produttività potrebbero essere mantenuti solamente ad altissimi costi attraverso l’impollinazione artificiale. Le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo.
La protezione degli insetti impollinatori, in particolare apoidei e farfalle, è quindi di fondamentale rilevanza, poiché essi svolgono un importante ruolo nell’impollinazione di una vasta gamma di colture e piante selvatiche.
Le api forniscono inoltre preziosi prodotti dell’alveare quali: miele, polline, pappa reale, cera, propoli, veleno, da sempre utilizzati ed apprezzati dall’uomo.
La maggior parte delle piante di interesse agricolo necessita degli insetti pronubi per l’impollinazione. A causa di alcune scelte della moderna agricoltura come la monocultura, l’eliminazione delle siepi e l’impiego dei fitofarmaci, nonché l’alterazione e la frammentazione delle aree naturali, l’ambiente è divenuto inospitale per la maggior parte degli insetti pronubi.
Il declino della presenza dei pronubi selvatici ha fatto si che l’importanza delle Apis mellifera sia diventata fondamentale per alcune colture.
In Europa, quasi metà delle specie di insetti è in grave declino e un terzo è in pericolo di estinzione. Il cambiamento dell’habitat e l’inquinamento ambientale sono tra le principali cause di questo declino. In particolare, l’intensificazione dell’agricoltura negli ultimi sei decenni e l’uso diffuso e inarrestabile dei pesticidi sintetici rappresenta uno dei principali fattori di decremento delle popolazioni e di perdita di biodiversità degli insetti pronubi negli ultimi tempi.”
La conclusione è chiara: o cambiamo subito il nostro modo di produrre cibo, oppure la maggior parte degli insetti arriveranno all’estinzione entro pochi decenni. Le ripercussioni che ciò avrà per gli ecosistemi del pianeta nei prossimi anni potrebbero essere molto gravi, poiché gli insetti sono la base strutturale e funzionale della maggior parte degli ecosistemi del Pianeta.
Il ripristino degli habitat naturali, insieme ad una drastica riduzione degli input agro-chimici e alla “riprogettazione” agricola, è probabilmente il modo più efficace per evitare ulteriori diminuzioni o scomparse degli insetti impollinatori, in particolare nelle aree ad agricoltura intensiva.
Ad esempio, filari, siepi e prati impiantate ai margini aumentano l’abbondanza di impollinatori selvatici, come pure la rotazione delle colture con trifoglio o altre leguminose può incrementare l’abbondanza e la diversità dei bombi, che a loro volta migliorano la resa delle colture e la redditività dell’azienda. Queste pratiche di “ingegneria ecologica” non solo favoriscono gli impollinatori, ma conservano anche i nemici naturali degli insetti che sono essenziali per contenere le specie di parassiti erbivori che attaccano numerose ed importanti colture.
Tuttavia, affinché queste misure siano efficaci, è fondamentale che gli attuali modelli di utilizzo dei pesticidi, principalmente insetticidi e fungicidi, siano ridotti al minimo per consentire il recupero delle popolazioni di insetti e dei relativi servizi di “controllo biologico” dei patogeni.
In molti dei sistemi agricoli, esso è ancora un mezzo sottoutilizzato, ma economicamente efficace e a basso impatto ambientale, in grado di preservare la biodiversità sia all’interno che al di fuori delle aziende agricole.”
La nuova politica agricola europea (PAC), introducendo meccanismi di incentivazione delle colture vegetali mellifere, ha recepito questo obiettivo. Aspettiamo i risultati.

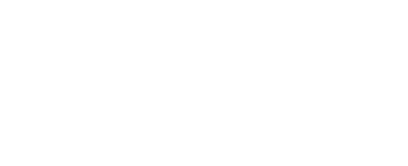




Il solito articolo di Ulderico Bisconti:interessante,preciso,di lettura scorrevole e coinvolgente.Complimenti