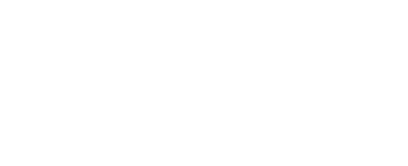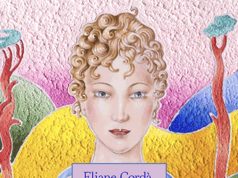Earth, Land, Soil sono termini che in italiano usano per lo più un solo vocabolo: Terra, come pianeta, come estensione che emerge dal mare, come suolo produttivo.
Qui parliamo di terra come fattore produttivo, come capitale da sfruttare per i bisogni della alimentazione, cui sono legate le sorti dell’Umanità. Ma non solo. Perchè la terra è anche potere in sé, è tornata prepotentemente ad esserlo, come dimostra il suo accaparramento (in inglese Land grabbing) e le modalità di come esso avviene determinano le strategie e i conflitti più recenti.
Comprare terra agricola non è più un gesto arcaico, né una semplice strategia di investimento: è un atto geostrategico. Gestire flussi finanziari, catturare benefici fiscali, controllare risorse vitali e accumulare opzioni politiche.
La terra, da bene rifugio, si è trasformata in infrastruttura strategica multifunzionale. È cash flow, è leva di potere, è strumento di sovranità. E oggi, nel cuore del XXI secolo, si lega a un’altra risorsa ancora più decisiva: l’acqua.
Il Land grabbing consiste nell’acquisizione su larga scala di grandi estensioni di terra da parte di aziende, governi o investitori privati, spesso senza il consenso delle comunità locali, per scopi di profitto, speculazione, coltivazione di prodotti da esportazione o per estrazione di risorse. Questo fenomeno, che ha visto una crescita significativa dopo la crisi finanziaria del 2008, porta all’espropriazione delle terre dei contadini e delle comunità, minacciando la loro sussistenza e la sovranità alimentare e può essere definito una forma moderna di colonialismo. Le terre vengono anche lasciate inattive.
L’argomento è stato molto importante nel passato, quando l’agricoltura rappresentava l’attività economica prevalente sia in termini di reddito prodotto sia in termini di occupazione e quando il mercato fondiario era estremamente attivo e vedeva acquirenti sostanzialmente di due tipi: a) quelli che ricercavano terre da coltivare direttamente; b) quelli che ricercavano nel bene fondiario un’occasione di investimento del proprio patrimonio e che, pur non coltivando direttamente la terra acquistata, la cedevano in uso secondo una contrattualistica ampia e diversificata. La proprietà terriera poteva essere anche data in garanzia a sostegno di finanziamenti. L’inurbamento per assecondare la Rivoluzione industriale ne trasformò parte in utilizzi speculativi e edilizi, connessi con l’espansione delle città.
La proprietà della terra ha importanti implicazioni per la struttura e lo sviluppo del settore agricolo, anche per nuove forme di sfruttamento (bio carburanti, pannelli solari, parchi eolici).
Questi utilizzi sono in competizione con la produzione alimentare con l’installazione di “campi di pannelli solari”, mentre nell’Unione Europea si utilizzano già 50 mila kmq di terreno coltivabile per produrre biodiesel da mais, soia, colza, girasole e bioetanolo da barbabietola da zucchero.
L’acquisizione di una grande quantità di terre agricole, spesso da parte di grandi attori o per consolidare attività esistenti, concentrandole in un’unica proprietà è proseguita in età più vicina alle nostre. Negli anni Ottanta uno dei maggiori proprietari terrieri fu il gruppo Ferruzzi, che si diceva ne possedesse una estensione, in molti continenti, mai raggiunta da altri nella storia.
Oggi alcuni Fondi di investimento specializzati si sono indirizzati verso questo investimento.
Un bene “a prova di recessione” che oggi è molto più: la nuova leva di potere del XXI secolo. Il 2025 vede crescere le acquisizioni di terreni agricoli tramite società veicolo (SPV e shell companies) con tre logiche: anonimato degli investitori, ottimizzazione fiscale, flessibilità nell’uso come asset finanziario. La terra agricola, da bene rifugio, si riconfigura come infrastruttura strategica multifunzionale. Il valore geopolitico del cibo è lampante: insicurezza alimentare in Africa e Medio Oriente, militarizzazione del grano e dei fertilizzanti: Russia-Ucraina, vulnerabilità delle supply chain. Possedere terra significa controllare produzione e leva politica.
A livello mondiale, queste tendenze assumono una valenza incommensurabile rispetto alle nostre più contenute dimensioni, diventando un vero e proprio fattore geopolitico. La Repubblica Popolare Cinese in Africa si sarebbe accaparrata 100 milioni di ettari di terreni agricoli fertili e di altre risorse naturali, in cambio della realizzazione di infrastrutture.
L’agricoltura emerge come elemento centrale delle iniziative del Piano Mattei per l’Africa, soprattutto considerando che il continente detiene il 60% delle terre coltivabili del Pianeta.
Si prevede che il cambiamento climatico andrà sempre più ad alterare le condizioni meteorologiche in termini di temperature, precipitazioni e portata dei fiumi, dalle quali dipende la produzione alimentare mondiale. Lo Stato Mondiale delle Risorse Terrestri e Idriche Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura ci porta qualche dato sullo sviluppo della Produzione agricola.
Terre in produzione
• Espansione delle terre destinate a colture alimentari tra il 1960 e il 2010: 12%.
Aumento della produttività agricola mondiale nello stesso periodo:150-200%.
Estensione totale delle terre coltivate (agricoltura pluviale + agricoltura irrigua) nel 1961: 1,4 miliardi di ettari.
Estensione totale delle terre coltivate (agricoltura pluviale + agricoltura irrigua) nel 2006: 1,5 miliardi di ettari.
Superficie coltivata con tecniche irrigue nel 1961: 139 milioni di ettari.
Superficie coltivata con tecniche irrigue nel 2006: 301 milioni di ettari.
Numero medio di ettari di terra coltivata necessari ad alimentare una persona nel 1961: 0,45 ettari. Numero medio di ettari di terra coltivata necessari ad alimentare una persona nel 2006: 0,22 ettari.
Uso delle terre: Superficie mondiale totale di terra idonea alla coltivazione: 4,4 miliardi di ettari.
Superficie totale globale coltivata su cui si pratica agricoltura pluviale: 80%. Superficie totale attualmente messa a coltivazione: 1,6 miliardi di ettari, di cui il 20% (0,3 miliardi di ettari) su terre marginalmente adattate all’agricoltura. Superficie mondiale di terra soggetta a degrado: 25%.
Superficie mondiale di terra moderatamente soggetta a degrado: 8%. Superficie mondiale di terra soggetta a recupero: 10%.
In molte regioni, problemi relativi alla qualità del suolo interessano oltre metà delle terre coltivate, specialmente in Africa Sub-Sahariana, in America del Sud, nel Sud-Est Asiatico e in Nord Europa.
Uso delle risorse idriche
Risorse idriche complessivamente prelevate a fini agricoli da falde acquifere, corsi d’acqua e laghi: 70%. Produzione agricola mondiale ottenuta tramite sistemi d’agricoltura pluviale: 60%. Ammontare di quanto normalmente l’irrigazione migliora la produttività agricola: il doppio. Volume delle coltivazioni cerealicole ad agricoltura pluviale nei paesi in via di sviluppo, in media: 1,5 tonnellate/ettaro.
Volume delle coltivazioni cerealicole ad agricoltura irrigua nei paesi in via di sviluppo: 3,3 t/ha. Numero medio di raccolti l’anno per le terre coltivate ad agricoltura pluviale in Asia: 1. Numero medio di raccolti l’anno per le terre coltivate ad agricoltura irrigua in Asia: 2.
Popolazione, terra e acqua
Popolazione mondiale che attualmente vive in regioni povere d’acqua: 40%. Numero di paesi che annualmente usano per l’irrigazione più del 40% (soglia considerata critica) delle loro risorse idriche: 11. Numero di paesi che prelevano annualmente il 20% delle loro risorse idriche, soglia che indica una notevole pressione e un forte rischio di scarsità d’acqua in futuro: 8. Risorse idriche rinnovabili attualmente consumate in Libia, Arabia Saudita, Yemen ed Egitto: 100%+. Risorse idriche rinnovabili attualmente consumate in America del Sud: 1% Diseguaglianze globali. Superficie arabile globale che si trova in paesi a basso reddito: 22%. Superficie coltivata pro capite in paesi a basso reddito: 0,17 ha; a reddito medio: 0,23 ha; ad alto reddito: 0,37 ha. La disponibilità media pro capite di terre coltivate nei paesi a basso reddito è pari a meno della metà di quella nei paesi ad alto reddito e l’adeguatezza delle terre arabili per le coltivazioni è generalmente inferiore. La superficie pro capite coltivata nei paesi ad alto reddito come gruppo (0,37 ha) è pari ad oltre il doppio di quella coltivata nei paesi a reddito medio (0,23 ha) e in quelli a basso reddito (0,17 ha).
Le implicazioni geostrategiche sono chiare:
Food security = sicurezza nazionale
Idro-politica: chi controlla l’acqua controlla la prossima scarsità globale
Carbon finance: la terra come asset ESG
Chi controlla la terra influenza anche le prospettive urbanistiche: conversione agricola/edificabile = moltiplicatore di valore. Nei Paesi emergenti il land grabbing anticipa la trasformazione d’uso; in quelli avanzati la zonizzazione diventa capitale politico.
Ad esempio, le proposte per bloccare il land grabbing per controllare i biocarburanti, o per utilizzare gli stock di alimenti per contenere la volatilità dei prezzi sui mercati agricoli sono state sostanzialmente accantonate. Soltanto la Repubblica Popolare Cinese in Africa si è accaparrata 100 milioni di ettari di terreni agricoli fertili e di altre risorse naturali, in cambio della realizzazione di infrastrutture.
Il fenomeno è esploso nel 2008, in concomitanza con la crisi economica e l’adozione di politiche di libero scambio che hanno facilitato l’acquisto di terre nei paesi del Sud del mondo.
Conseguenze:
In parallelo, la spinta ESG genera crediti di carbonio: riforestazione e pratiche rigenerative, un flusso di reddito finanziarizzato.
Il 2025 segna un’accelerazione nelle acquisizioni di terreni agricoli attraverso società veicolo, fondi sovrani e family office.
 La nuova aristocrazia del capitale, fondi del Golfo, investitori asiatici, private equity occidentali, non compra solo suolo. Compra futuro. Perché possedere terra oggi significa controllare acqua, cibo, carbonio e, in prospettiva, politica.
La nuova aristocrazia del capitale, fondi del Golfo, investitori asiatici, private equity occidentali, non compra solo suolo. Compra futuro. Perché possedere terra oggi significa controllare acqua, cibo, carbonio e, in prospettiva, politica.
Il valore geopolitico del cibo è sotto gli occhi di tutti: guerre del grano, embargo sui fertilizzanti, insicurezza alimentare in Africa e Medio Oriente, vulnerabilità delle catene di approvvigionamento.
Chi controlla la produzione agricola dispone di una leva diplomatica enorme. È la logica che un tempo si applicava al petrolio, oggi è estesa alla biopolitica alimentare e idrica.
La terra è cash flow stabile, spesso fiscalmente agevolato. Ma la vera moneta nascosta è l’acqua.
Ogni appezzamento agricolo è, in realtà, un deposito di diritti idrici. Questi possono essere scissi, negoziati, rivenduti. In un’epoca di stress climatico e desertificazione, l’acqua è più preziosa della terra stessa.
Acquisire suolo significa, in prospettiva, assicurarsi accesso a bacini, falde e corsi fluviali: la materia prima invisibile della geopolitica contemporanea.
La transizione energetica, spesso narrata come sfida tecnologica e finanziaria, poggia anch’essa su un fondamento idrico. Dietro ogni batteria, ogni turbina, ogni microchip, scorre acqua.
Per produrre una singola tonnellata di litio servono fino a due milioni di litri d’acqua. Per fabbricare un microchip avanzato occorrono decine di migliaia di litri di acqua ultrapura. L’intelligenza artificiale, la frontiera più avanzata della tecnologia, consuma acqua per raffreddare i data center e per alimentare la produzione dei semiconduttori che la rendono possibile.
La “mente digitale” dell’umanità funziona, letteralmente, grazie a un bene naturale che sta diventando politico.
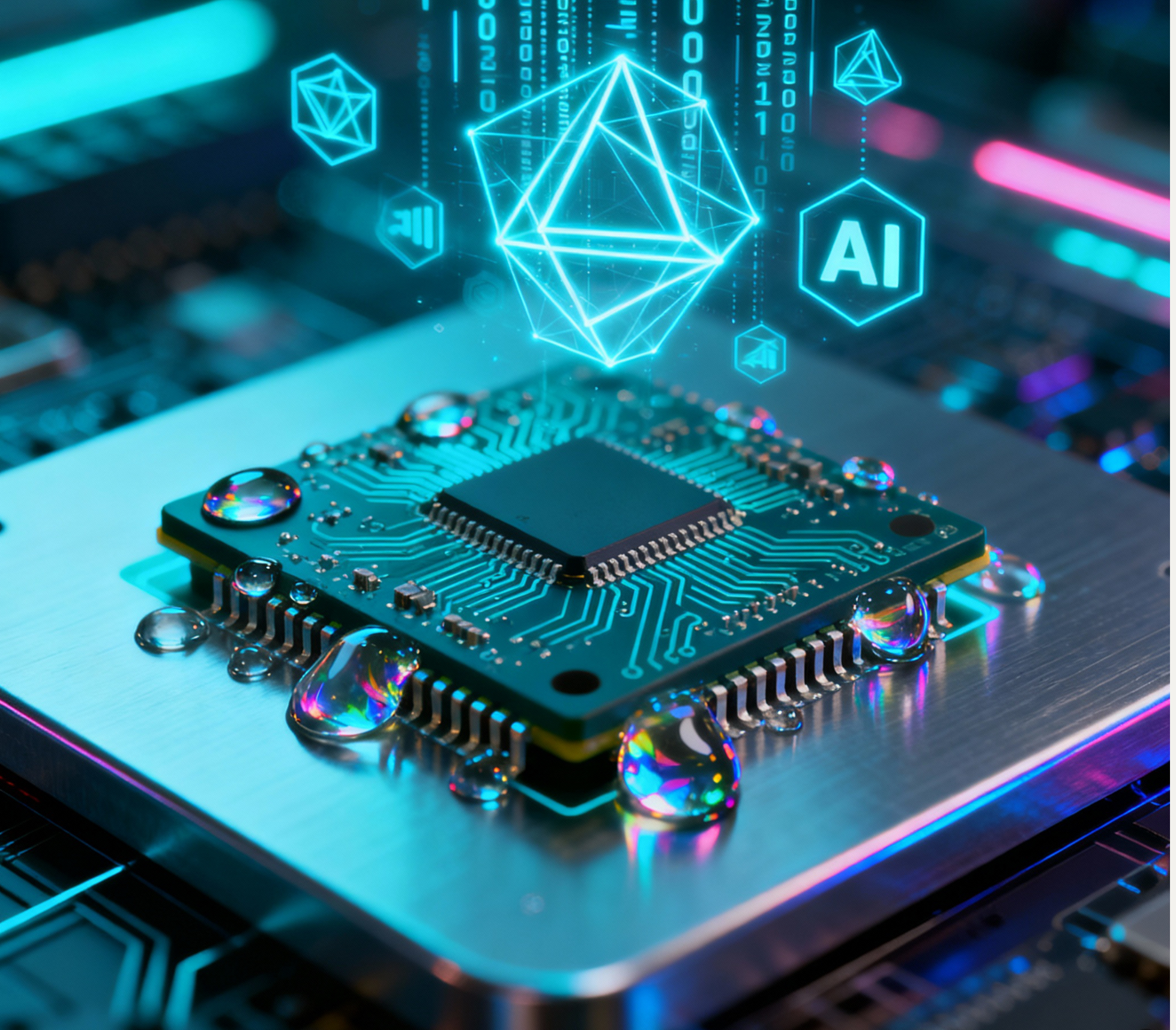 Il controllo delle risorse idriche è già oggetto di tensioni crescenti: Iran e Talebani si scontrano per il fiume Helmand; la diga del GERD in Etiopia ridefinisce i rapporti di forza lungo il Nilo; la Cina, con la diga di Motuo sul Brahmaputra, mette sotto pressione l’India.
Il controllo delle risorse idriche è già oggetto di tensioni crescenti: Iran e Talebani si scontrano per il fiume Helmand; la diga del GERD in Etiopia ridefinisce i rapporti di forza lungo il Nilo; la Cina, con la diga di Motuo sul Brahmaputra, mette sotto pressione l’India.
L’acqua è il nuovo campo di battaglia invisibile, una forma di deterrenza che unisce hard e soft power. Chi regola portate, dighe e infrastrutture idriche esercita un dominio paragonabile al controllo di uno stretto marittimo.
In questo scenario, la hydro-diplomacy diventa la prosecuzione della geopolitica con altri mezzi. E la terra agricola, con i suoi pozzi, falde e diritti d’acqua, ne è il punto di contatto fisico.
Acquistare terra oggi significa collocarsi nel cuore del sistema di approvvigionamento del futuro: alimentare, energetico, industriale e tecnologico.
La posta in gioco è geopolitica. Food security equivale a sicurezza nazionale, Hydro-politica significa controllo sulla prossima scarsità globale. Carbon finance è la nuova finanza di influenza.
E c’è un rischio sottile, soprattutto per Paesi come l’Italia: vendere terra e risorse idriche equivale, nel medio periodo, a cedere porzioni di sovranità. Chi controlla il suolo, controlla la produzione. Chi controlla l’acqua, controlla la vita.
E chi controlla entrambi, definisce l’ordine geopolitico del futuro.