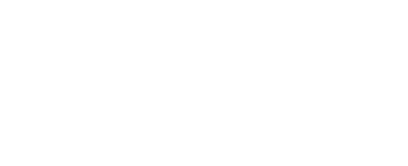Nel 160° anniversario dell’elezione a capitale del Regno d’Italia, Firenze non appare soltanto come “città di passaggio” nell’Unità nazionale: fu il cuore di una trasformazione istituzionale, economica e culturale che la proiettò al centro del mondo moderno.
Tra il 1865 e il 1871 la città visse un periodo irripetibile, in cui la politica di Bettino Ricasoli e la spinta delle élite bancarie e intellettuali crearono un laboratorio di modernità: qui nacquero la futura Banca d’Italia, una nuova urbanistica, la stampa libera e una società che seppe fondere tradizione e progresso.
Il 3 febbraio 1865 Firenze accoglieva Vittorio Emanuele II e il Parlamento del Regno d’Italia, diventando capitale. Quel trasferimento, che a Bettino Ricasoli apparve come «una tazzina di caffè avvelenato», segnò una svolta storica per la città .
Il “caffè” di cui parlava il Barone di Ferro si tramutò presto nei conti salati di una trasformazione urbana senza precedenti: la città contrasse debiti ingenti per rifarsi il volto, proprio mentre il sogno diventava realtà la capitale del regno si trasferiva a Roma, nel 1871.
Eppure, quell’azzardo economico e civile consegnò a Firenze un patrimonio di idee e infrastrutture che avrebbe inciso sul destino dell’Italia intera.
Il 18 novembre 1865, Palazzo Vecchio ospitò, nel Salone dei Cinquecento, la prima seduta del Parlamento, simbolo di un’Italia giovane e ancora in cerca di un centro di gravità istituzionale. In quegli anni la città non si limitò a ricevere il potere: lo interpretò, traducendo in architettura, arte e finanza la nascita di un’identità nazionale.
Bettino Ricasoli rappresentò la sobrietà toscana al servizio della costruzione dello Stato. Nel suo temperamento austero e in quella celebre frase sul “caffè avvelenato” si legge la consapevolezza del compito: governare una città fragile, orgogliosa e improvvisamente esposta allo sguardo del mondo.
Già sindaco di Firenze, fondatore de La Nazione, presidente del Consiglio e mediatore fra Casa Savoia e il Vaticano, Ricasoli fu il simbolo di una modernità severa, ma concreta. Credeva nel progresso come equilibrio tra ordine e libertà, tra economia e morale pubblica.
Sotto la sua influenza, Firenze divenne il luogo in cui la politica si fece etica civica: il centro ideale per un’Italia che cercava la propria misura tra ambizione e responsabilità.
Accanto a lui, il sindaco Ubaldino Peruzzi e poi Cambray Digny, che con pragmatismo e visione, accompagnarono la città nel difficile compito di adattarsi a capitale del Regno, tra cantieri, piani regolatori e un senso diffuso di fervore civile.
La Firenze capitale non fu solo sede del Parlamento, ma cuore pulsante di una nuova economia nazionale.
Qui la Banca Nazionale del Regno d’Italia costruì la sede centrale in via dell’Oriuolo, in un edificio progettato per rappresentare solidità e modernità. È da questo sistema, regolato durante gli anni fiorentini, che nascerà nel 1893 la Banca d’Italia, con le sue radici profondamente ancorate alla cultura bancaria toscana.
Le grandi famiglie finanziarie dei Fenzi, Peruzzi, Bastogi, contribuirono a fare di Firenze una piccola Londra mediterranea. Le banche toscane dialogavano con Parigi, Londra e Vienna; i capitali circolavano tra i palazzi e i caffè del centro storico, dove si discuteva di politica, di moneta e di ferrovie.
In quegli anni si progettarono le prime linee telegrafiche e ferroviarie che avrebbero collegato l’Italia al resto d’Europa, e Firenze divenne un nodo cruciale nella rete di comunicazioni del Paese.
Nel Salone dei Cinquecento, cuore politico di Firenze, l’“Apoteosi di Cosimo I” domina la volta con la rappresentazione allegorica del potere civile e dell’ordine cosmico.
L’opera, che celebra la grandezza della Toscana come entità statuale, riflette la volontà di fondere arte e politica in una stessa tensione ideale: quella di un potere illuminato e armonioso.
Quasi in contemporanea, nel 1865, Constantino Brumidi dipingeva nel Campidoglio di Washington l’“Apoteosi di George Washington”, simbolo della nascente repubblica americana.
Due città, due capitali, due epoche unite dalla stessa idea: rappresentare la sovranità come elevazione morale.
Firenze e Washington, nello stesso anno, affrescarono il proprio sogno politico: l’una nel segno dei Medici e del Rinascimento civile, l’altra in quello della democrazia repubblicana. Entrambe indicarono che la grandezza di una nazione passa prima di tutto attraverso la cultura.
La trasformazione urbanistica di Firenze fu radicale. L’architetto Giuseppe Poggi ridisegnò la città secondo i canoni delle capitali europee: i viali di circonvallazione, il nuovo quartiere della Mattonaia, il Viale dei Colli e Piazzale Michelangelo, pensato come balcone simbolico della nuova Italia.
Le mura medievali vennero in parte demolite, le piazze ampliate, i palazzi ristrutturati per ospitare ministeri e uffici pubblici. In pochi anni Firenze divenne un luogo urbano in cui la storia si piegava alla modernità, con lamentele e applausi, ma senza mai spezzarsi.
La città, da museo vivente del Rinascimento, si fece capitale viva, capace di ospitare ambasciate, banche, telegrafi e giornali: una capitale nella quale la bellezza diventava funzione civile.
Attorno a questa Firenze “moderna” si muoveva un mondo intellettuale internazionale.
A Villa Palmerino, sulle colline, vissero e scrissero personalità come Vernon Lee (pseudonimo di Violet Paget), una delle prime donne intellettuali ad affermarsi in un ambiente dominato da uomini, e in seguito Virginia Woolf e John Maynard Keynes, che proprio in Toscana trovò l’atmosfera che lo condusse alle prime riflessioni sull’economia come strumento morale.
Villa Palmerino divenne un crocevia di scrittori, pensatori e filosofi: da Henry James a Edith Wharton, da Berenson al gruppo di Bloomsbury. Fu il segno di una Firenze che, anche dopo la fine del suo ruolo politico, restò capitale culturale dí riferimento del mondo anglosassone.
Qui nacquero le prime riviste letterarie europee dirette da donne, spesso costrette a usare pseudonimi maschili, ma libere nel pensiero. È la stessa Firenze che aveva accolto la stampa libera di Ricasoli, ora divenuta capitale spirituale della modernità.
Forse, dopo centosessant’anni, Firenze continua a interrogarsi sul significato della parola “capitale”.
Allora costruiva futuro tra le impalcature dei viali e le idee di Ricasoli; oggi sembra cercarlo tra le pieghe di un’eredità troppo grande per essere solo ricordata.
Il mondo è andato avanti, ma non sempre in meglio: la velocità ha sostituito la visione, e la bellezza quella vera, civile, condivisa resta spesso un frammento da restaurare.
Eppure Firenze, anche così, conserva un primato raro: quello di ricordarci che la modernità non è un’epoca, ma un atteggiamento dello spirito.
Forse non siamo andati molto più lontano di allora; ma se ancora, passando sotto le volte del Salone dei Cinquecento, sentiamo che la bellezza può essere una forma di governo, allora qualcosa di quella capitale del mondo non si è mai spento davvero.