
Nella Giornata Mondiale della Filosofia di oggi 20 novembre 2025, promossa dall’UNESCO, sfatiamo il mito che la filosofia sia una disciplina fine a se stessa e indifferente ai nostri problemi quotidiani. Questo articolo nasce dall’esperienza di Chiara Punzi, medico in formazione specialistica in Psichiatria presso l’Università degli Studi di Ferrara (2021-2025), e dalla sua riflessione sulla presenza di ingiustizia reale nelle storie di vita degli utenti dei Servizi di Salute Mentale. Nella preparazione della tesi per il diploma post laurea di Specializzazione, il suo obiettivo è stato la restituzione il più gentile, fedele e autentica possibile della complessità dei vissuti degli utenti.
Lo studio di Chiara si inserisce nel contesto del progetto internazionale EPIC – Epistemic Injustice in Healthcare, Università di Bristol, Nottingham e Birmingham, finanziato da Wellcome Trust Discovery Award e diretto da Havi Carel dell’Università di Bristol. Il caso analizzato si propone di utilizzare gli strumenti dell’analisi filosofica e dell’indagine psicologica qualitativa per comprendere le esperienze vissute da adulti afferenti ai Servizi di Salute Mentale pubblici italiani che nella loro presentazione clinica avessero un consistente livello di paranoia, valutato attraverso il colloquio clinico psichiatrico. Per tale ragione, il caso di studio che è stato messo in piedi nella cornice del progetto EPIC è denominato «Prejudicing Paranoia». La ricerca mira a rispondere a questioni critiche quali: se questi utenti si sentano ascoltati, accolti e compresi dagli operatori sanitari e dalle persone care nella propria vita quando parlano delle loro idee o esperienze, come vedano se stessi e le loro relazioni in rapporto al mondo che li circonda, e se abbiano subìto episodi di discriminazione a causa della condizione di salute o della diagnosi psichiatrica.
La speranza è che le risposte a queste domande possano contribuire a migliorare l’equità e la qualità della comunicazione e dell’assistenza clinica. È importante in Psichiatria adottare un approccio che metta al centro la persona, la sua voce, la sua dignità e la lotta contro l’ingiustizia sociale.
La Redazione
La ricerca e l’ingiustizia epistemica
Nella ricerca messa in piedi per questa tesi di Specializzazione in Psichiatria, alcuni valori fondamentali sono stati messi al centro. Le persone sofferenti sono state la ragione primaria e il punto cui i ricercatori sono ritornati costantemente, nelle diverse fasi di progettazione e esecuzione dello studio. La responsabilità nei confronti della loro voce e la protezione dell’intimità del loro dolore ha rappresentato il connotato etico che ha vagliato l’agire. Infine, la restituzione dei loro desideri e speranze è stato il focus definitivo, con la convinzione che psichiatra è colei o colui che riesce a vedere nell’Altro un soggetto di esperienza e volontà, emozione e pensiero, mistero e sogno.
Nel 2007 la filosofa Miranda Fricker ha introdotto la nozione di ingiustizia epistemica. Si tratta di una forma di ingiustizia in cui una persona viene danneggiata nella sua capacità di acquisire e condividere conoscenza a causa di pregiudizi identitari. Non credere alla testimonianza di un soggetto solo perché ha una diagnosi di schizofrenia, ad esempio, ancora prima di aver considerato i fatti narrati, è un esempio di ingiustizia epistemica, perché la credibilità e autorevolezza del soggetto vengono “pregiudicate”, messe in discussione senza una ragione lecita. In altri casi di ingiustizia epistemica, detta ermeneutica, il soggetto non dispone invece delle risorse interpretative necessarie per comprendere e comunicare la propria esperienza in un modo che sia riconosciuto dalla cultura dominante:
«Poveri genitori contadini/ Certo siete invecchiati e ancor temete/
Il signore del cielo e gli acquitrini/ Genitori che mai non capirete/
Che oggi il vostro figliuolo è diventato/ Il primo fra i poeti del paese»
canta Branduardi citando liberamente il poeta russo S.A. Esenin: i genitori del poeta sono vittime dell’ingiustizia ermeneutica causata dalla povertà e dalla marginalizzazione di classe che avevano impedito loro di apprendere gli strumenti interpretativi per comprendere il figlio letterato.
Tali circostanze di ingiustizia reale possono prodursi anche in contesti sanitari; ancor più rischioso, per sua stessa natura, è in questo senso il contesto psichiatrico, dove gli operatori si confrontano su base quotidiana con idee sulla realtà e sulle relazioni molto differenti da quelle usuali. Può accadere infatti in ambito psichiatrico, e ancor più con utenti con paranoia, che venga interpretato tutto ciò che essi narrano come falso, dovuto ai sintomi del disturbo psichico. Questa circostanza costituisce un esempio di «generalizzazione dal locale al globale»: poiché in alcune circostanze una persona ha detto cose che si sono poi rivelate frutto di pensieri patologici, si arriva a derubricare ogni cosa detta da quella persona come sintomo. Ma tale situazione non si concilia con il valore personale, relazionale o spirituale che il soggetto potrebbe dare a quell’esperienza, né ammette la possibilità che il soggetto sia stato vittima nel mentre di un’esperienza di reale danneggiamento.
Da quando Michel Foucault ha evidenziato il legame inestricabile tra potere e sapere, mostrando come ciò che può essere detto in un determinato momento storico dipende strettamente da ciò che il pensiero dominante consente di dire, è facile individuare la Psichiatria come un campo particolarmente esposto all’ingiustizia epistemica, per via dell’asimmetria di potere tra personale sanitario e utenti. Il modello psichiatrico tende a “colonizzare” lo spazio epistemico del soggetto, imponendo le proprie categorie di significato e riducendo il discorso del paziente a mera espressione di psicopatologia, ovvero a un sintomo. Si verifica un paradosso: il paziente è al centro della diagnosi, ma la sua voce può essere delegittimata se non coincide con il paradigma medico dominante. Inoltre, gli utenti della Salute Mentale possono essere esposti a ulteriori forme di marginalizzazione come disoccupazione, povertà, isolamento sociale, patologie mediche croniche, che, sommate, li rendono invisibili.

Il caso della paranoia
Il fenomeno della paranoia offre un contesto di studio cruciale in questo senso, poiché il trattamento psichiatrico rischia di ridurre rapidamente i vissuti di sfiducia a mera patologia, ignorando la possibilità che siano radicati in reali esperienze passate di ingiustizia o marginalizzazione. L’invalidazione costante dell’esperienza del paziente da parte degli operatori può amplificare il vissuto di ingiustizia e la sfiducia. L’ingiustizia epistemica può anche minare la capacità del paziente di agire autonomamente e partecipare ai processi decisionali che lo riguardano. L’Antropologia Medica è un sapere che relativizza e contestualizza le categorie della medicina, evidenziando gli aspetti culturali specifici del contesto entro il quale si sviluppano tali categorie; la paranoia, da una prospettiva antropologica, può essere vista come un bisogno estremo di attribuire significato alle proprie esperienze, un tentativo di dare ordine a una realtà soverchiante, caotica o realmente minacciosa.
Nello studio, condotto dai ricercatori presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) del Policlinico Umberto I di Roma e presso il Servizio Psichiatrico Ospedaliero Intensivo (SPOI) dell’Ospedale del Delta di Lagosanto, si è esplorato il significato delle esperienze dei partecipanti, il rapporto tra la loro diagnosi e il modo in cui gli altri considerano o svalutano le loro testimonianze, la loro sensazione di essere più o meno efficaci nel dare un senso e una direzione alla propria vita e la loro idea dello stigma associato ai disturbi psichici.
Alcuni risultati preliminari
Come ci si aspettava, i vissuti dei partecipanti sono caratterizzati da una relazione ambivalente con l’altro, divisi tra un atteggiamento che essi stessi hanno definito «ingenuo» e un desiderio di fiducia e autenticità da un lato, e la paura di essere giudicati e/o aggrediti e la diffidenza dovuta alle cattive esperienze passate dall’altro. Si alternano così, nelle narrazioni di sé, momenti di chiusura a momenti in cui prevale il bisogno di connessione e relazione sociale.
Inoltre, emerge una forte consapevolezza dello stigma che la società associa ai problemi di salute mentale e ai loro trattamenti – come ad esempio i farmaci – e l’aspetto più doloroso per gli intervistati è lo «stigma interiorizzato». Accade infatti che chi è vittima di pregiudizi e, di conseguenza, viene discriminato, può giungere ad “assorbire” quei pregiudizi e a divenire al contempo soggetto e oggetto di quella discriminazione. Diversi dei partecipanti vedono le persone con problemi di salute mentale come svantaggiate e degne di commiserazione e affermano di non credere che ci siano altre possibilità che non esser trattate come «poveri pazzi» (citazione testuale da un’intervista). Di pirandelliana memoria, alcuni partecipanti descrivono la necessità di indossare «maschere» per sopravvivere alla società dell’apparenza e della performance, nascondendo fragilità e dolore, in una continua tensione tra il desiderio di essere autentici e il bisogno di adattarsi.
Un aspetto interessante emerso dalle interviste è inoltre la dinamica tra conquista e perdita di “agenzialità”, intesa come sensazione soggettiva di poter prendere in mano la propria vita in maniera responsabile, consapevole e autonoma. Essi sentono che è possibile per loro intervenire sul mondo circostante per ottenere i propri obiettivi, ma devono confrontarsi con ostacoli continui, che possono essere dentro di sé o imposti dalla società, e che quando riescono a “prendere in mano” la propria vita è sempre dietro l’angolo il rischio reale di perderla di nuovo. Il senso di autoefficacia è vissuto dunque come una conquista fragile, mai pienamente raggiunta, e sempre minacciata da etichette diagnostiche, stigma e dinamiche di potere. Inoltre, dei vissuti degli intervistati colpisce che la più dolorosa perdita di autonomia si sperimenta spesso nelle “piccole cose” della vita quotidiana, come la privazione degli oggetti personali da parte di familiari o personale infermieristico o il fatto che i familiari li taglino fuori dalla possibilità di «scegliersi i vestiti che hanno addosso». La sofferenza dunque non deriva solo dai grandi eventi traumatici, che pure sono molto importanti, ma anche dalle “piccole cose” della vita apparentemente insignificanti, e, d’altra parte, dalla violenza che Paul Farmer chiama «strutturale»: alcuni intervistati menzionano anche la violenza delle istituzioni, sanitarie e non, ovvero, la violenza della struttura storico-politica di un determinato contesto in cui la malattia si produce.
Il contributo della filosofia per un approccio più inclusivo e dialogico alla cura
In attesa di completare l’analisi delle interviste, queste prime osservazioni mettono in luce come l’ingiustizia epistemica, la sensazione di perdita di autonomia e credibilità e lo stigma siano fenomeni intrecciati che si alimentano a vicenda. L’ingiustizia epistemica si concretizza nella negazione della voce e della credibilità del paziente, spesso a causa di pregiudizi legati alla diagnosi. Questa negazione porta a una compromissione della capacità di agire e di essere riconosciuti come protagonisti della propria vita, in grado di perseguire obiettivi propri con efficacia. Lo stigma, infine, agisce sia dall’esterno che dall’interno, influenzando profondamente l’identità e la percezione di sé.
Nonostante la sofferenza, nei racconti dei partecipanti emerge anche una quota di speranza: ogni “barriera” rappresentata contiene nelle parole stesse degli intervistati, in forme diverse e personali, una chiave per essere permeata, superata o distrutta. Che sia la possibilità di «aprire gli occhi», di «rompere il guscio», di attraversare «il labirinto» o di varcare «un muro di vetro» – alcune delle immagini evocate nella descrizione delle “barriere” che li ostacolano – i partecipanti mostrano desiderio e capacità di resistenza e immaginazione di un futuro migliore.
Questa indagine restituisce uno spaccato vivido e complesso della vita delle persone con paranoia afferenti ai Servizi di Salute Mentale, mostrando come la sofferenza sia spesso amplificata da barriere invisibili, ma anche come la narrazione e l’espressione siano un modo per attribuire significato alle proprie esperienze, che ne possono venire in tal modo alleviate. Lo studio, con i limiti del caso, invita a proseguire sulla strada di una ricerca scientifica e di una pratica clinica all’insegna del detto latino «non multa, sed multum»: non molte cose, ma molto in profondità. Utilizzare metodi che ricercano così in profondità e conferiscono così tanta attenzione ai singoli casi potrebbe ridurre le esperienze di ingiustizia epistemica che si producono nel contesto psichiatrico, in quanto permettono agli operatori di toccare con mano una complessità e una profondità degli utenti che spesso non emerge nei contesti sanitari abituali, segnati dalla logica aziendalistica e dalla performance di budget sanitario.
Nonostante i limiti, la ricerca ha dato voce a chi spesso resta ai margini: persone portatrici di storie complesse, dolorose, nella narrazione dominante frequentemente ridotte a mere vittime di traumi, spesso segnate da marginalità sociale, discriminazione e una lunga frequentazione dei Servizi di Salute Mentale, e che invece posseggono dimensioni contrarie meritevoli di ascolto: speranza, resistenza, capacità di rialzarsi, desiderio.
Ha messo in risalto alcuni aspetti fondamentali:
- Nelle relazioni con gli altri, gli utenti dei Servizi di Salute Mentale spesso perdono credibilità e autorevolezza come soggetti di conoscenza, non venendo creduti o finendo per essere “silenziati”, non solo sui contenuti patologici, ma sulla ogni loro pensiero. Questo sposta il focus della sofferenza dalla “malattia” reputata interna al soggetto all’interazione dello stesso con l’ambiente circostante e alle sue relazioni sociali.
- La diagnosi e il pregiudizio sociale hanno un impatto diretto e devastante sul senso di autonomia e di essere padroni della propria esistenza, dando luogo in alcuni casi a un drammatico senso di esclusione. Questo suggerisce che la guarigione o il miglioramento non dipendono solo dalla riduzione dei sintomi, ma dalla riconquista di un ruolo sociale attivo e di una credibilità interpersonale.
In sintesi, come molti fondamentali Autori hanno più volte segnalato nella storia della Psichiatria, anche questa indagine sposta l’attenzione dalla patologia vista come “difetto individuale”, a una prospettiva che la interpreti come un’esperienza complessa in cui i temi di potere, fiducia, ruolo e relazione sono fondamentali almeno quanto i sintomi stessi. Gli strumenti della filosofia possono contribuire a un approccio più inclusivo e dialogico in psichiatria, riducendo le barriere epistemiche e le disuguaglianze di potere.
Chiara Punzi e Lisa Bortolotti

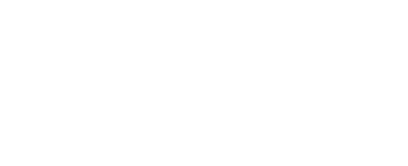
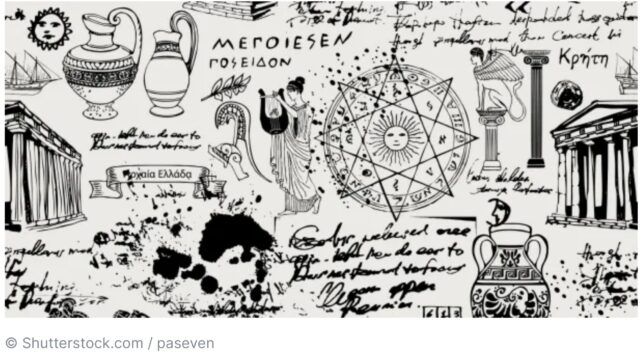


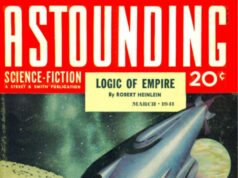
Bellissimo articolo. Molto attuale anche per il momento storico, socio-politico, particolarmente complicato che stiamo vivendo.
Personalmente ho attenzionato “Da quando Michel Foucault ha evidenziato il legame inestricabile tra potere e sapere, mostrando come ciò che può essere detto in un determinato momento storico dipende strettamente da ciò che il pensiero dominante consente di dire, è facile individuare la Psichiatria come un campo particolarmente esposto all’ingiustizia epistemica, per via dell’asimmetria di potere tra personale sanitario e utenti.”
E poi “Di pirandelliana memoria, alcuni partecipanti descrivono la necessità di indossare «maschere» per sopravvivere alla società dell’apparenza e della performance, nascondendo fragilità e dolore, in una continua tensione tra il desiderio di essere autentici e il bisogno di adattarsi.”
Due frasi contenute nell’interessante articolo, che prendendo spunto della celebrazione della giornata della filisofia viene a parlare del disagio mentale.
Fenomeno che – in maniera cosciente o no – interessa moltissimi soggetti con i quali interagiamo e ci relazioniamo; osservazioni utili per capire se mantenenre esclusi dalle sindromatologie, seppur marginalmente, anche noi stessi.
Complimenti alle autrici.
Gentilissimo Toti, credo di poter parlare anche a nome della Prof.ssa Bortolotti nel ringraziarla di cuore per l’attento sguardo che ha dedicato alle nostre riflessioni, e per averne colto dei passaggi cui abbiamo tenuto in maniera particolare.
Personalmente ritengo che la sofferenza psichica ci riguardi tutti in prima persona, e che ci chiami in causa a un livello personale e politico ancor prima che, in alcuni casi, professionale. Grazie ancora per l’opportunità di dialogo e alla prossima occasione!