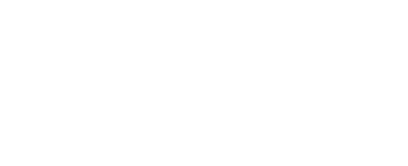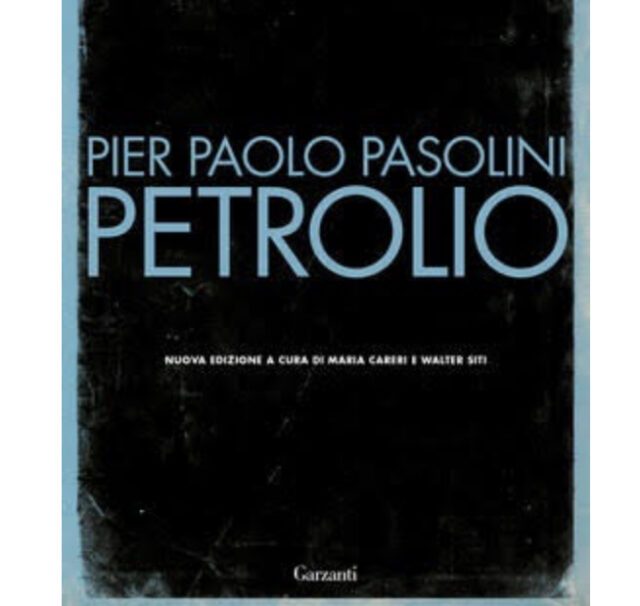Sfogliandola, lessi un testo che mi spiazzò: il discorso del presidente dell’ENI e successivamente di Montedison, tenuto nel 1972 all’Accademia Militare di Modena. Un discorso in apparenza neutro, ma in realtà densissimo di implicazioni politiche e morali. Parlava del potere come di una “necessità naturale” da imparare, di una classe dirigente che doveva “educare” il Paese alla modernità, alla nascita delle multinazionali.
Pasolini fu ossessionato da quel lungo discorso. Lo riconobbe come il manifesto di un nuovo potere invisibile, più sottile e più pervasivo di quello politico. Quando, pochi anni dopo, iniziò a scrivere Petrolio, quel discorso divenne una delle chiavi di tutto il romanzo: un atto d’accusa contro la mutazione genetica dell’Italia industriale.

Pasolini comprese che il potere economico non si nascondeva più dietro i governi, ma li generava e li sostituiva. Aveva intuito che la morte di Enrico Mattei non fu solo la fine di un uomo, ma la perdita dell’autonomia energetica e morale dell’Italia che tornava sotto un’egemonia economica straniera travestita da progresso.
Il 2 novembre 1975, quella voce si spense all’Idroscalo di Ostia. Dopo l’omicidio, il manoscritto Petrolio scomparve in parte: alcune carte furono ritrovate, altre no. Quel che rimase venne conservato nel Fondo Pasolini di Firenze. Il suo archivio era immenso e disperso: diari, appunti, lettere, sceneggiature, quaderni di lavoro. Serviva un luogo neutrale ma autorevole, capace di custodire quelle carte con rigore e indipendenza. Firenze, più raccolta e meno esposta di Roma, divenne la scelta naturale. A volerlo fu Graziella Chiarcossi, cugina e collaboratrice del poeta, insieme a studiosi come Maria Corti e Franco Zabagli, che scelsero il Gabinetto Vieusseux per garantire una tutela sobria e scientifica, lontana da ogni pressione mediatica.

Nel 1980 nacque ufficialmente il Fondo Pasolini, oggi cuore pulsante degli studi sull’autore, con oltre 70.000 documenti manoscritti, dattiloscritti, lettere, taccuini, fotografie e bobine sonore — che ancora raccontano la voce inquieta di chi non volle mai smettere di cercare la verità.
Il 2 novembre del 1975 non morì solo un poeta, morì la possibilità di dire la verità su un Paese che aveva smesso di ascoltare e di credere in se stesso.
Petrolio, fu pubblicato ben venti anni dopo, nel 1992 durante Tangentopoli, il periodo che mise a nudo quel sistema di corruzione che Pasolini aveva già intuito vent’anni prima ed aveva scritto nel romanzo incompiuto; l’Italia stava vivendo la fine della Prima Repubblica. l’ENI, le tangenti e i rapporti tra politica e affari erano al centro del dibattito nazionale. In questo contesto, la casa editrice Einaudi decise di pubblicare Petrolio, curato da Maria Corti, filologa e studiosa del fondo pasoliniano.
Fu un gesto quasi “storico”: perché il libro apparve come una profezia postuma. Tutto ciò che Pasolini aveva intuito, il legame tra potere economico, morale e mediatico, adesso si manifestava sotto gli occhi di tutti. Un libro che racconta la nascita di una borghesia industriale e politica capace di controllare il linguaggio, la televisione e il denaro, molto prima che Tangentopoli rivelasse la rete di corruzione tra imprese e partiti.
Tra le sue pagine si intravedono riferimenti cifrati all’ENI, ai servizi segreti, ai rapporti occulti tra Stato e finanza. Pasolini non era certo un complottista: era un analista poetico, e questo lo rese pericoloso. Forse Petrolio fu proprio la sua condanna. Disse di star lavorando su “qualcosa di pericoloso”, e dopo la sua morte, alcune delle sue carte scomparvero. Nessuno ha mai saputo dove siano finite.
Negli stessi anni, il suo cammino incrociò quello di Oriana Fallaci. Due caratteri inconciliabili, ma uniti da un medesimo coraggio: dire ciò che gli altri tacevano. Lei lo intervistò per L’Europeo, lo provocò, lo difese, Pasolini le rispose: “Oriana, tu sei una moralista travestita da cinica”. Eppure, quando lui morì, fu lei a scrivere la frase più vera:
“Era un uomo libero. E lo hanno ucciso perché era libero.”

a New York, come documentato dal servizio fotografico che lei realizzò per la rivista. Un testo del 1966.
Pasolini aveva capito che la rivoluzione del consumo sarebbe stata più devastante di quella politica.
Nel 1974 scriveva: “Il potere non si nasconde più, si mostra.”
La televisione, la pubblicità, i nuovi linguaggi: tutto serviva a formare un nuovo tipo umano, più docile e più solo.
L’Italia non doveva più essere censurata: bastava insegnarle a desiderare ciò che la rendeva dipendente.
A cinquant’anni dalla sua morte, la domanda resta intatta:
chi controlla i nostri desideri?
Il petrolio che allora scorreva nelle vene del potere oggi è l’informazione, l’immagine, l’algoritmo. Cambiano le forme, non la sostanza.
Raccontare Pasolini non è solo un esercizio di memoria, la sua voce continua a chiedere se abbiamo ancora il coraggio di guardare il potere senza innamorarci di lui.
Quella notte del 2 novembre 1975, in un campo di calcio di periferia, finì la partita dell’Italia che cercava la verità.
Da allora, forse, non è mai più ricominciata.