
La protesta degli agricoltori dilaga anche in Italia e ora la questione si inserisce a pieno titolo nella Guerra dei Dazi, salvo la moratoria e gli aggiustamenti già attuati o promessi. La confusione è al massimo.
L’Unione Europea ha massacrato gli agricoltori per anni, demolendo il lavoro di generazioni che praticavano un’agricoltura “tradizionale”, già non sufficientemente remunerativa.
Ha sconcertato allevatori e imprenditori agricoli. Li ha dipinti come nemici del clima, addirittura ha equiparato le aziende agricole a stabilimenti industriali. Li ha accolti a Bruxelles con i cavalli di frisia fuori dal Parlamento Europeo. Stanno operando affinché gli agricoltori abbandonino i terreni che non entrino in avvicendamento e sui quali non sia praticata alcuna coltura nel corso dell’annata agraria.
Questa politica ha prodotto la chiusura di imprese agricole favorendo i consumi dei prodotti extra UE, senza che venissero richiesti gli stessi standard di sicurezza alimentare che hanno imposto ai nostri imprenditori. Ha imposto una burocrazia di formalismi, fiscalismi, lungaggini ed inefficienze, con aumento dei costi di produzione. Ha chiesto addirittura di abbattere gli animali, perché inquinano e propone di mettere vincoli ecologici sui prati-pascoli. Gli “ecoschemi” rappresentano una delle principali novità della Pac 2023/2027, con specifiche misure volte a tutelare il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, destinati agli agricoltori in attività̀, impegnandoli ad applicare le rigide pratiche ivi previste.
Tra le regole del Bio e quelle degli ecoschemi PAC, le produzioni agricole europee sono destinate a diminuire, aumentando gli acquisti da altri Paesi senza le stesse garanzie sui prodotti. Con il doppio svantaggio delle quantità e della qualità. Si chiedono sacrifici agli agricoltori, ma poi si finanzia la carne sintetica e si danno nulla-osta alle multinazionali per diffondere l’uso alimentare di grilli e cavallette. L’Unione ha inseguito per anni gli slogan dell’attivista Greta Thunberg, vedendo nell’agricoltura il nemico da demolire. L’agricoltura è vita, cultura, storia, tutela del territorio in cui l’opera dell’uomo ha saputo convivere in armonia con la natura.

Una breve ricapitolazione
La crescita esponenziale della popolazione, che secondo le stime FAO dovrebbe arrivare a 10,5 miliardi di individui nel 2050; i processi di inurbamento, che comporteranno la concentrazione del 60% della popolazione nelle città; unitamente all’aumento delle disponibilità di reddito della popolazione di grandi nazioni quali Cina e India porteranno ad una esplosione della domanda di prodotti di origine animale e vegetale. Finora l’agricoltura, attraverso il miglioramento delle tecniche, l’aumento delle superfici coltivate e il maggior consumo d’acqua e di energia, è riuscita a far fronte all’aumentata domanda di cibo, anche se gli squilibri nella distribuzione consegnano al primo decennio del ventunesimo secolo quasi 1 miliardo di persone sottonutrite o addirittura affamate. In futuro la domanda di cibo, in particolare di prodotti di origine animale, dovrà essere soddisfatta in maniera sostenibile in quanto la disponibilità di terra e degli altri fattori della produzione non sono risorse illimitate. Questo lavoro delinea problemi e propone alcune soluzioni volte a dare una risposta sostenibile alla crescente domanda, attraverso un’analisi dettagliata dell’Animal Footprint, ossia dell’impronta ecologica relativa alle produzioni zootecniche.
Il diffuso degrado e la crescente scarsità delle terre e delle risorse idriche stanno mettendo a rischio un gran numero di sistemi di produzione alimentare chiave in tutto il mondo, costituendo una seria minaccia alla possibilità di riuscire a sfamare la popolazione mondiale afferma un nuovo rapporto dell’Organizzazione per il cibo e l’agricoltura (la Fao).
Cosa sta succedendo
Lo Stato mondiale delle risorse idriche e fondiarie per l’alimentazione e l’agricoltura (Solaw) sottolinea che sebbene negli ultimi 50 anni ci sia stato un notevole aumento della produzione mondiale, “in troppe occasioni tali miglioramenti sono stati accompagnati da pratiche di gestione delle risorse che hanno degradato gli ecosistemi terrestri e idrici dai quali la produzione alimentare stessa dipende”.
Troppa gente e troppo inquinamento
Ad oggi un gran numero di questi ecosistemi “sono esposti al rischio di un progressivo deterioramento della loro capacità produttiva, a causa dell’effetto congiunto di un’eccessiva pressione demografica e di usi e pratiche agricole non sostenibili”, dice il rapporto. Nessuna regione è immune: ecosistemi a rischio si trovano in ogni parte del mondo, dalle montagne della Cordigliera Andina alle steppe dell’Asia Centrale, dal bacino fluviale del Murray-Darling al centro degli Stati Uniti.
Il clima cambia e condizionerà la produzione
Si prevede che il cambiamento climatico andrà sempre più ad alterare le condizioni meteorologiche in termini di temperature, precipitazioni e portata dei fiumi, dalle quali dipende la produzione alimentare mondiale.
Meno risorse, più persone
Di conseguenza, afferma il Solaw, la sfida di fornire cibo a sufficienza ad un pianeta sempre più affamato non è mai stata tanto grande, specialmente nei paesi in via di sviluppo, dove terre fertili, nutrienti del suolo e le risorse idriche sono più scarse.
Il 25% della superficie agricola mondiale è degradata
Il Solaw fornisce per la prima volta una valutazione globale sullo stato delle terre del pianeta. Ben un quarto di esse è fortemente degradato. Un altro 8% è moderatamente degradato, il 36% è stabile o leggermente degradato e il 10% è classificato come “in miglioramento”. Le restanti quote delle superfici agricole terrestri sono completamente brulle (il 18%) o coperte da bacini idrografici interni (circa il 2%).
Un degrado anche di biodiversità
La definizione di degrado usata dalla Fao non fa riferimento al semplice degrado del suolo e delle risorse idriche in sé, ma include anche altri aspetti degli ecosistemi colpiti, come ad esempio la perdita di biodiversità. Vaste aree in tutti i continenti stanno subendo un degrado delle terre, con un’ incidenza particolarmente alta nella costa occidentale delle Americhe, nella regione mediterranea dell’Europa Meridionale e del Nord Africa, nella regione del Sahel e del Corno d’Africa, e in tutta l’Asia. La minaccia maggiore è la perdita della qualità del suolo, seguita dalla perdita di biodiversità e dall’esaurimento delle risorse idriche. Oltre 1,6 miliardi di ettari delle terre migliori e più produttive a livello mondiale sono attualmente usate per colture agricole. Una parte è soggetta a un progressivo degrado a causa di pratiche agricole che facilitano l’erosione del suolo da parte di acqua e vento, la perdita di materiale organico, la compattazione del terreno in superficie, la salinizzazione e l’inquinamento del suolo e la perdita dei nutrienti.
La scarsità di risorse idriche e l’inquinamento stanno aumentando
La scarsità dell’acqua sta aumentando, così come anche la salinizzazione e l’inquinamento delle falde acquifere e il degrado delle risorse idriche e in generale degli ecosistemi ad esse legati, riporta il Solaw. I bacini idrici interni subiscono la pressione dell’effetto combinato di una riduzione dell’afflusso d’acqua e di un maggiore carico di nutrienti – l’accumulo eccessivo di nutrienti come il nitrogeno e il fosforo. Molti fiumi non arrivano a raggiungere le loro foci naturali e le zone umide stanno via via sparendo. Nelle principali zone di produzione cerealicola in tutto il mondo, l’enorme prelievo dalle falde acquifere stà riducendo notevolmente le riserve d’acqua sotterranea, andando così ad esaurire quello stock di scorta di risorse idriche sulle quali le comunità rurali fanno totale affidamento.
La trappola della povertà: meno accesso a terre e acqua
In tutto il mondo, i più poveri hanno minor accesso alle terre e all’acqua e sono costretti in una trappola della povertà caratterizzata da piccole fattorie con terreni di scarsa qualità ed altamente vulnerabili al degrado del suolo e all’incertezza delle condizioni climatiche”, sottolinea il rapporto. Circa il 40% delle terre considerate degradate a livello mondiale si trova in zone con alti tassi di povertà. Tuttavia, segno che il degrado delle terre costituisce una minaccia per tutti i livelli di reddito, il 30% delle terre degradate si trova in aree con livelli di povertà moderati ed il 20% in aree a bassi livelli di povertà.
Cibo, il mondo ha riserve soltanto per 116 giorni (dati allarmanti)
Il livello nei silos è ai minimi mentre riparte la speculazione sulle terre e i biocarburanti.
Le riserve nel 2002 erano il 29,9% del consumo annuo. Oggi siamo solo al 21%. La sopravvivenza di un essere umano richiede 1.800 chilocalorie al giorno.
I Ministri dell’agricoltura del G20 riuniti per la prima volta a Parigi nel 2011 per far fronte all’impatto della crisi economica sul settore agricolo minacciato dalla volatilità dei prezzi. Dal 2015 si incontrano annualmente per discutere di sicurezza alimentare, nutrizione e sviluppo globale dell’agricoltura.
Ad esempio, le proposte per bloccare il land grabbing(l’accaparramento di terre nei Paesi in via di sviluppo da parte di società o stati del mondo ricco), per controllare i biocarburanti, o per utilizzare gli stock di alimenti per contenere la volatilità dei prezzi sui mercati agricoli sono state sostanzialmente accantonate. Soltanto la Repubblica Popolare Cinese in Africa si sono accaparrati 100 milioni di ettari di terreni agricoli fertili e di altre risorse naturali, in cambio della realizzazione di infrastrutture.
Ci si dovrà accontentare di altri studi di fattibilità (gli ennesimi) in vista delle prossime riunioni internazionali. Come spiegava Marco De Ponte, segretario generale di ActionAid Italia, «siamo ancora molto lontani dall’adozione di politiche capaci di riportare stabilità nei mercati agricoli e garantire la sicurezza alimentare». Intanto soltanto nel 2009 in Africa sono state accaparrati terreni pari alla superficie dell’intera Francia da fondi speculativi o sovrani; per i sussidi agli agricoltori dei paesi Ocse si spendono 385 miliardi di dollari, 80 volte gli aiuti allo sviluppo all’agricoltura. E quasi un miliardo di persone vivono in condizioni di fame.
Diversamente da quanto facciamo noi oggi, l’accumulazione di riserve alimentari fu una preoccupazione di Egizi, Cinesi e Romani, con la costruzione di depositi di alimenti base e politiche per calmierarne i prezzi in caso di carestie. Nelle crisi 2007-2008 Che uccisero per fame decine di milioni di persone, mettendone a rischio altre centinaia di milioni, si scoprì che non esiste un sistema coordinato a livello mondiale per gestire le riserve di cibo in caso di crisi alimentari. E’ una vera emergenza.
Si dovrà discutere di un uso coordinato delle riserve alimentari. Coordinato, perché le riserve esistono anche oggi: come è sempre stato nella storia dell’umanità, sono proprio i cereali (grano, riso, mais, soia, miglio, sorgo e così via) gli alimenti che insieme ad altri minori dal punto di vista delle quantità (olii di semi o da piante, latte in polvere, pesce o carne conservata) possono essere manipolati e accumulati per periodi più o meno lunghi prima che siano danneggiati e inutilizzabili. Ovviamente, conservare cereali ha un forte costo: secondo le stime Unctad, il costo di mantenere una riserva di cereali è pari al 15-20% del valore. Attualmente secondo la Fao le riserve mondiali (pubbliche, cioè statali, o di privati) dall’ultimo Bollettino sulla domanda e l’offerta di cereali fissa a 785 milioni di tonnellate la produzione mondiale di grano, a 1.511 milioni di tonnellate la produzione di cereali secondari – in crescita del 2,7 percento dal 2022 – e a 523,1 milioni di tonnellate la produzione mondiale di riso.
Nonostante la revisione al ribasso di questo periodo, nel periodo 2023-2024, l’utilizzo di cereali a livello mondiale, stimato in 2 804 milioni di tonnellate, dovrebbe superare dello 0,8 percento il risultato dello scorso anno, con un maggior quantitativo di grano che sarà destinato al consumo come alimento, anziché come mangime, mentre l’utilizzo di riso, a livello mondiale, dovrebbe attestarsi attorno ai 520,5 milioni di tonnellate. Quest’ultimo dato suggerirebbe una seconda stagione consecutiva di crescita zero o negativa dell’indice di utilizzo, in un contesto in cui il protrarsi dei tagli agli utilizzi non alimentari andrebbe a controbilanciare l’incremento del consumo di riso.
Al termine della stagione 2024, le scorte mondiali di cereali sono stimate in 884 milioni di tonnellate, superando i livelli iniziali del 3% e facendo, così, segnare un valore record. La nuova previsione relativa alle scorte finali, che è stata rivista al rialzo, associata a stime più pessimistiche, si traduce in un rapporto mondiale tra riserve e utilizzo di cereali del 30,8 percento.
Quanto al commercio mondiale di tutti i cereali nel periodo 2023-2024, l’ultima stima dalla FAO conferma il volume di 466 milioni di tonnellate, con una contrazione annua dell’1,7 percento, rispetto al livello del 2022-2023.
È vero che a parte l’elevato costo di mantenimento, le riserve di alimenti spesso producono effetti di distorsione dei mercati, penalizzando produzioni e produttori. E – soprattutto – aprendo la strada a fenomeni di corruzione e mala gestione. Specie in certi Paesi poveri dove anche gli aiuti internazionali vengono incamerati dalle élites che controllano il potere. Non è un caso se negli anni 80, molti sistemi nazionali di gestione delle riserve vennero abbandonati. Vero è che, come spiega un recente rapporto di Oxfam, se nel 2007-2008 fossero state messe sul mercato 105 milioni di tonnellate di cereali, al costo di 1,5 miliardi di dollari, il boom dei prezzi sarebbe stato bloccato. Una bella spesa in cifra assoluta, non c’è che dire. Ma soltanto 10 dollari a testa per ognuno dei 150 milioni di umani travolti dalla fame per colpa di quella crisi. Tra l’altro, già oggi esistono riserve «anticrisi» in paesi come Cina, India, Brasile, Indonesia, Mali, Canada e Malawi. E altri 35 (Burkina Faso, Cambogia, Camerun, Etiopia, Kenya, Nigeria, Pakistan e Senegal tra questi) le hanno attivate durante l’emergenza alimentare del 2007-2008.
Raccomandazioni
Sarà cruciale migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse idriche a fini agricoli, afferma il rapporto. La maggior parte dei sistemi d’irrigazione in tutto il mondo sono gestiti al di sotto delle loro potenzialità. Una strategia che combini una miglior gestione dei sistemi di irrigazione, investimenti in conoscenze tecniche locali e in tecnologie moderne, maggiore formazione e sviluppo delle capacità, potrà migliorare l’efficienza nel consumo delle risorse idriche. In più, pratiche agricole innovative come l’agricoltura conservativa, le pratiche agro-forestali, i sistemi integrati di coltivazioni/allevamento e di irrigazione/acquacoltura promettono di aumentare la produzione in modo efficiente per combattere l’insicurezza alimentare e la povertà, limitando l’impatto sugli ecosistemi. Un’altra area chiave in cui è necessario intervenire è l’aumento degli investimenti in sviluppo agricolo. La protezione e lo sviluppo delle terre, la conservazione del suolo e il controllo delle alluvioni richiederanno ulteriori 160 milioni di dollari per lo stesso periodo, riporta il Solaw. Infine, dovrebbe esser data maggiore attenzione non solo alle opzioni tecniche per migliorare l’efficienza e promuovere un’intensificazione sostenibile, ma anche a far si che le politiche e le istituzioni nazionali vengano modernizzate, siano coordinate tra loro e più preparate ad affrontare le nuove sfide odierne in materia di gestione dell’acqua e del suolo.
Insomma è necessaria una serie di scelte di investimento e di coordinamento anche con altri sistemi, non misure burocratiche o dazi in difesa di prodotti e territori o ancor meno scelte ideologiche non sostenibili. Spesso frutto di mode per una facile acquisizione di consenso, in nome di un vuoto ambientalismo.
L’Unione Europea in questa prospettiva mondiale deve aver cura delle proprie tipicità, deve saper investire con lungimiranza e deve evitare di superare le proprie contraddizioni aggirandole. La delocalizzazione agricola potrebbe produrre gli errori prodotti da quella manifatturiera, imponendo retromarce costose e affannosi inseguimenti di opportunità perdute. Come pure regole cervellotiche che hanno solo lo scopo di scoraggiare qualsiasi visione di lungo periodo. Saprà essere della partita planetaria o si arroccherà in posizioni confinate e alla fine autolesioniste?

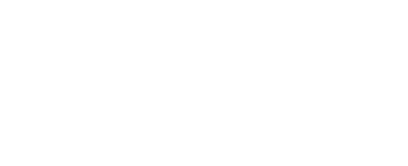


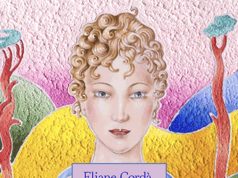
Davvero un ottimo articolo, che condivido pienamente. Purtroppo non mi pare che la politica tenga conto di questi argomenti: le cosiddette “élites” sazie e viziate stanno preparando un collasso alimentare a spese, al solito, dei poveracci!